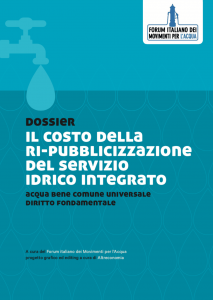Simpatico articolo di Giorgio Ieranò del 26.09.2019 su 24ilmagazine
Se Greta si fosse presentata al Pireo con una trireme verde, probabilmente l’avrebbero affondata. Per gli antichi, la natura era una risorsa da sfruttare senza troppi scrupoli. Eppure, già a quei tempi si parlava di emergenza rifiuti, disboscamenti indiscriminati, città congestionate. Tanto che Giulio Cesare inventò la Ztl
Le foreste dell’Amazzonia sono bruciate per tutta la scorsa estate. Ardevano, così ci è stato spiegato, perché i fazendeiros brasiliani cercavano nuovi spazi per le terre coltivate. Al vertice di Biarritz, i Paesi del G7 hanno lanciato l’allarme e hanno offerto fondi per salvare il polmone verde del pianeta. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha risposto in modo sprezzante: «Usate quei soldi per riforestare l’Europa». Bolsonaro, si sa, ha un piglio autoritario, se non dittatoriale. Ma quello che è successo quest’estate in Amazzonia, in effetti, succede anche in Europa da secoli. Anzi, da millenni. Già Platone, nel suo breve dialogo Crizia (lo stesso in cui si tratta del mito della favolosa Atlantide), accenna alla deforestazione del territorio di Atene. Un tempo i dintorni della città erano fertili e coperti di boschi, mentre ora, scrive il filosofo, appaiono assai più nudi e aridi: le colline si sono inscheletrite, assomigliano a «ossa di un corpo malato». Un argomento ripreso alcuni anni dopo, con più forza, da Teofrasto, grande naturalista e discepolo prediletto di Aristotele. Il quale notava anche come la deforestazione mettesse a rischio tutto l’equilibrio ecologico di un territorio. Tagliando i boschi, scriveva, diventano più facili le inondazioni, perché le radici degli alberi trattengono invece l’acqua. Inoltre, si producono anche mutamenti climatici: la temperatura tende ad alzarsi.
Questa consapevolezza delle trasformazioni ambientali è diffusa in tutto il mondo antico. Anche in età romana si sottolineava come l’intervento degli uomini avesse ridotto notevolmente le aree verdi. L’Aventino, notava lo storico Dionigi di Alicarnasso, «un tempo era coperto di alberi di ogni genere: ora invece è tutto occupato da costruzioni». Ma, allora come oggi, questa coscienza, che potremmo definire “proto-ecologica”, si scontrava con gli interessi economici e con il desiderio di mettere a profitto le terre. Il geografo Eratostene testimonia che, già ai suoi tempi, tre secoli prima di Cristo, il governo accordava sconti fiscali per chi disboscava, a sue spese, le foreste trasformandole in zone che potevano essere sfruttate per la produzione di legname, per le coltivazioni, per i pascoli. Viceversa, però, una legge dell’isola egea di Kos, risalente più o meno agli stessi anni, che possiamo ancora leggere perché è rimasta incisa su due iscrizioni, stabiliva pene severe per chi avesse osato tagliare gli alberi del bosco sacro al dio della medicina Asclepio per far legna. Era uno scrupolo religioso che, però, si traduceva, nei fatti, in una precoce attenzione alla tutela dell’ambiente.
Insomma, benché il termine e il concetto di ecologia siano moderni (la parola è stata inventata nel 1886 dal zoologo tedesco Ernst Haeckel), anche gli antichi erano consapevoli che il rapporto tra l’uomo e l’ambiente era dinamico e presentava aspetti problematici. Ed erano problemi che non riguardavano solo le foreste o le aree extraurbane: anche per garantire un’esistenza decente agli abitanti di molte città antiche era spesso necessario prendere provvedimenti drastici. Metropoli come Alessandria d’Egitto o Roma erano spesso sovraffollate, con abitazioni malsane e seri problemi igienici. L’inquinamento urbano esisteva già allora. Già ad Atene, in epoca classica, si ponevano, per esempio, questioni che di solito consideriamo modernissime, come lo smaltimento dei rifiuti urbani o l’abusivismo edilizio. Alcuni funzionari pubblici, racconta Aristotele, avevano il compito di sorvegliare che nessuno gettasse immondizie entro due chilometri dalle mura cittadine. E dovevano anche impedire la costruzione di edifici irregolari o di balconi che aggettavano sulle pubbliche vie.
Persino il problema del traffico non riguarda solo le città moderne e non nasce con l’invenzione delle automobili. Se uno legge le opere di Seneca, Giovenale o Plinio il Giovane, vi trova una sequela di lamentele sull’intasamento delle strade di Roma: il rumore, i conducenti di carri che guidano come pazzi, gli incidenti frequenti, i veicoli che bloccano la circolazione. E forse non tutti sanno che anche la Ztl, la Zona a traffico limitato, l’hanno inventata i romani antichi. Un anno prima di morire, nel 45 a.C., Giulio Cesare firmò la Lex Iulia Maiestatis, che alcuni considerano l’antenata di tutti codici della strada. Stabiliva, tra l’altro, che durante le ore diurne i carri non potevano entrare nel centro cittadino, esclusi quelli della nettezza urbana e pochi altri autorizzati. Ma, alla fine, tra gli antichi prevaleva senz’altro l’idea che civiltà significasse domare e dominare la natura, tagliare i boschi per creare campi coltivabili, costruire città sfruttando al massimo tutte le risorse naturali del suolo, estraendo il marmo dalle cave e ricavando il legno dalle foreste.
Nel quinto libro del De rerum natura, Lucrezio esalta il progresso umano individuandone un momento saliente proprio nel disboscamento, nella conquista di nuovi territori per l’agricoltura: gli uomini, scrive con entusiasmo, «ogni giorno di più costringevano i boschi ad arretrare sui monti, a lasciare spazio per la coltivazione». Gli antichi, al contrario di quanto talvolta si crede, non avevano in genere un religioso rispetto per la sacralità della madre terra. La natura, per loro, era quasi sempre matrigna: un nemico insidioso, un ostacolo da superare. Le foreste vergini dovevano lasciare il posto a costruzioni e città. Per gli ateniesi del tempo di Pericle, costruire navi con cui commerciare e combattere era più importante che salvaguardare i boschi.
Se Greta si fosse presentata al Pireo con una trireme ecologica, probabilmente l’avrebbero affondata. E, altrettanto probabilmente, greci e romani avrebbero avuto molta comprensione per il punto di vista dei fazendeiros brasiliani che hanno dato fuoco all’Amazzonia. Ma questo non significa che dobbiamo anche noi pensarla allo stesso modo. E non solo perché i tempi cambiano. Ma anche perché, bisogna pur dirlo, gli antichi non avevano sempre ragione.